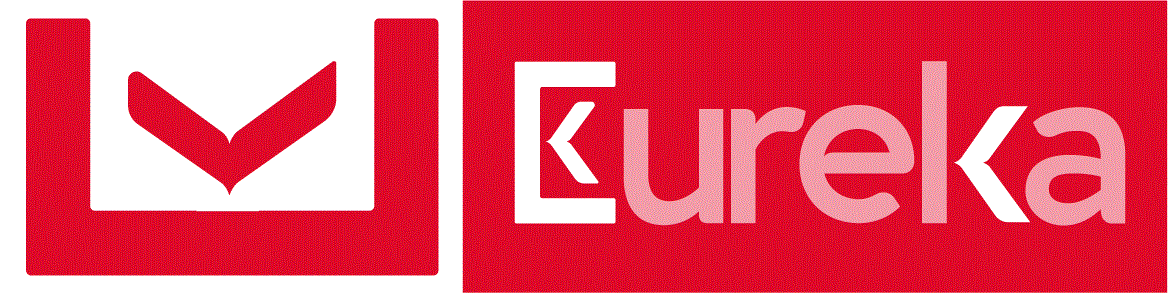"Mi sia concesso di cominciare con una confessione piuttosto imbarazzante: per tutta la mia vita nessuno mi ha dato piacere più grande di David Bowie. Certo, forse questo la dice lunga sulla qualità, della mia vita. Non fraintendetemi. Ci sono stati momenti belli, talvolta persino insieme ad altre persone. Ma per ciò che riguarda una gioia costante e prolungata attraverso i decenni, nulla si avvicina al piacere che mi ha dato Bowie." (Simon Critchley, Bowie) Quelli che non conoscono l’opera di Bowie, temo, avranno provato un po’ d’irritazione per la quantità di cose dette e scritte dopo la sua morte nel gennaio scorso. O perlomeno stupore, viste le innumerevoli sfaccettature per cui è stato ricordato. Come ha scritto giustamente Francesco Adinolfi su Il manifesto del 12 gennaio, “non c’è un solo Bowie, e ognuno ha il suo Bowie da piangere”. C’è ovviamente il Bowie che tra la fine dei ’60 e i primi anni ’70 porta in scena la libertà contro la soffocante pubblica morale, mescolando generi ed identità sessuali in canzoni e concerti, ostentando i suoi personaggi scandalosi per sbatterli in faccia a family day di ogni sorta. Lo scrittore Hanif Kureishi, per esempio, ricorda la canzone “Rebel rebel” (1974) come una spinta che lo porta a desiderare di andarsene dal monotono perbenismo del sud di Londra. Il filosofo Simon Critchley descrive l’impatto di “Rock’n’roll suicide” (1972), dove l’urlo “You’re not alone!” (“Non sei solo”!) diventa detonatore emotivo per una generazione di giovani a disagio con se stessi e con il mondo, spingendoli a cercare di diventare qualcos’altro – “qualcosa di più libero, più queer (traducibile con ‘eccentrico’, e anche ‘omosessuale’), più sincero, più aperto, e più eccitante.” Ma questo Bowie, l’icona del gender bending, è stracitato. Molto meno noto è il Bowie dall’animo irriducibilmente politico. Intendiamoci, anche dal punto di vista politico Bowie è stato molte cose. Nel 1975 rilascia alcune dichiarazioni di simpatia verso il nazismo, che saranno poi rettificate e (molto parzialmente) giustificate con la sua pericolosa dipendenza dalle droghe di quel periodo. Il clamore è amplificato da una fotografia in cui sembra fare il saluto romano a una folla di fan che lo attende a Victoria Station (ma osservando il filmato dell’evento su Internet, pare che il fotografo abbia preso lo scatto proprio nel momento in cui il braccio si tende in un normalissimo saluto). Si tratta di un aspetto delicato ancora da chiarire completamente, in cui anche critici raffinati come Critchley non si avventurano troppo. E che comunque ha finito per offuscare, secondo me, la figura di Bowie cantore degli ultimi e dei margini. Il nodo cruciale di questo suo aspetto è l’album Scary Monsters (1980), alla fine di un decennio segnato da una serie di album memorabili, dal glam rock alle sperimentazioni berlinesi – storicamente, la fine delle utopie e l’inizio del cosiddetto riflusso. Nel brano “Ashes to ashes” Bowie riprende il personaggio che l’aveva portato al successo, il Maggiore Tom, astronauta che in “Space oddity” (1969) celebrava l’allunaggio ma al contempo si perdeva stranamente a galleggiare nello spazio. Seguendo una parabola analoga agli ideali bruciati di quel periodo, nel 1980 Major Tom ricompare travolto dalle droghe pesanti, schiavo dei mostri che lo perseguitano nello spazio: I want an axe to break the ice, I want to come down right now Ashes to ashes, funk to funky We know Major Tom’s a junkie strung out in heaven’s high hitting an all-time low Voglio un’ascia per rompere il ghiaccio, voglio venir giù subito Cenere alla cenere, funk al funky Lo sappiamo che Major Tom è un tossico sperso nell’alto dei cieli caduto in una depressione storica Ma anche la realtà in cui Major Tom desidera tornare non promette nulla di buono. In Scary Monsters si manifesta uno dei punti più alti della critica socio-politica nei testi di Bowie, che assume toni quasi profetici. Mi riferisco alla canzone che apre l’album, “It’s no game (no. 1)”: Silhouettes and shadows watch the revolution No more free steps to heaven and it’s no game (…) Documentaries on refugees couples ‘gainst the target (…) Draw the blinds on yesterday and it’s all so much scarier Put a bullet in my brain and it makes all the papers Profili e ombre guardano la rivoluzione Niente più passi facili verso il paradiso e non è un gioco (…) Documentari su rifugiati coppie nel mirino (…) Chiudi la finestra sul passato ed è tutto più spaventoso Sparami un colpo in testa e ne parleranno tutti i giornali Qui Bowie sembra svelare quella che sarà la faccia oscura degli anni ’80 e oltre: la questione dei rifugiati e delle vittime civili dei conflitti (come suonano profetici quei due versi…), l’oblio degli ideali del passato, lo sguardo onnipresente ma banalizzante dei mass media. E’ importante ascoltare “It’s no game (no. 1)” anche perché Bowie canta questa canzone a squarciagola, a voce quasi stridula, come se lo stessero torturando; l’insieme è reso più complesso dall’alternanza con una voce femminile che canta in giapponese una traduzione del testo, in tono aggressivo. Secondo Critchley, “il genio di Bowie risiede nell’armonizzare minuziosamente parole e musica attraverso il mezzo della voce”. I versi finali della canzone introducono poi un riferimento più esplicitamente politico, forse riferendosi alla polemica menzionata sopra: So where’s the moral? People have their fingers broken To be insulted by these fascists – it’s so degrading And it’s no game E allora dov’è la morale? La gente ha le dita spezzate Venir insultati da ’sti fascisti – è così degradante E non è un gioco La voce di Bowie si contorce soprattutto quando pronuncia il titolo della canzone, “non è un gioco”: il dramma della ‘fine delle ideologie’ sta nel poter non prendere più nulla sul serio, neanche le grandi tragedie. C’è una coincidenza curiosa, a questo proposito. L’anno seguente Giorgio Gaber mette in scena il recital Anni affollati, e nel pezzo parlato “Il presente” offre (ovviamente con Sandro Luporini) una caustica riflessione sul nuovo clima dei primi anni ’80, dove i più bravi e geniali riescono a togliersi di dosso la pesantezza di qualcosa che ingombra per dedicarsi allo ‘smitizzante’. Perché di fronte all’idiozia dei vecchi moralisti, preferisco vedere l’uomo di cultura che si fa fotografare nudo su un divano a fiori. Eh sì, per questa sua capacità di saper vivere il gioco. Sto parlando insomma di quelli veramente colti, che con sottile ironia hanno riscoperto… l’effimero. Ecco che cos’è il presente: l’effimero. E devo dire che per della gente come noi, che non crede più a niente, questo è perfetto. (…) La cosa più intelligente da fare è quella di giocare d’astuzia con i segnali del tempo. Ma attenzione, perché tra l’avere la sensazione che il mondo sia una cosa poco seria, e il muovercisi dentro perfettamente a proprio agio, esiste la stessa differenza che c’è tra l’avere il senso del comico ed essere ridicoli… La canzone di Bowie non finisce qui, perché Scary Monsters ha una struttura circolare e si chiude con “It’s no game (no. 2)” (“Non è un gioco, parte seconda”), dove viene riproposto lo stesso motivo – o quasi. Questa versione accentua la critica sociale (e la visionarietà profetica) aggiungendo una strofa finale sullo sfruttamento del lavoro minorile: Children ‘round the world put camel shit on the walls Making carpets on treadmills, or garbage sorting And it’s no game Bambini in tutto il mondo mettono cacca di cammello sui muri Fanno tappeti su macchinari, o frugano in discariche E non è un gioco Ma soprattutto, i versi di questa “parte seconda” sono cantati in modo radicalmente diverso, con voce lenta, calda, modulata, quasi da crooner in stile Frank Sinatra, quasi a voler dire: guardate che anche i miei pezzi apparentemente più commerciali possono essere qualcosa di più di semplici canzoni orecchiabili. E’ una caratteristica dei suoi testi che viene colta anche dalla genialità sregolata di Lars Von Trier, il cui durissimo film Dogville (2003), sulla brutalità del sogno americano, si conclude con la scena del massacro di un intero villaggio e uno stacco improvviso sui titoli di coda: una sequenza di immagini di povertà e degrado statunitense con in sottofondo il pezzo “Young Americans” (1975), dal ritmo allegro ma con un sottotesto che accenna alla sterilizzante massificazione degli individui: We live for just these twenty years, do we have to die for the fifty more? Viviamo solo per questi vent’anni, dobbiamo morire per altri cinquanta? Questa ambivalenza è riscontrabile soprattutto nei dischi immediatamente successivi a Scary Monsters, quelli segnati da un disimpegno che per la prima volta fanno diventare Bowie un fenomeno commerciale mainstream, e che molti fan ancora rifiutano. Mi riferisco innanzi tutto a Let’s Dance (1983), ovviamente, ricordando il videoclip della canzone omonima che mette in primo piano la condizione degli aborigeni australiani; come scrive Nicholas Pegg nel suo enciclopedico The Complete David Bowie, “prendendo spunto solo marginalmente dal testo della canzone per sposare la causa dei diritti degli aborigeni, il video costituisce il primo (sic) sostanziale esempio del ruolo da militante sociopolitico che Bowie cominciava a ritagliarsi negli anni ’80.” Sempre in Let’s Dance, il brano “Ricochet” (“Pallottola di rimbalzo”) è pervaso da un senso di totale sacrificabilità delle vite umane; come in “It’s no game”, i versi sembrano già descrivere il lato oscuro della globalizzazione neoliberista: Like weeds on a rock face waiting for the scythe (…) These are the prisons, these are the crimes teaching life in a violent new way (…) Early, before the sun, they struggle off to the gates in their secret fearful places, they see their lives unraveling before them (…) But when they get home, damp-eyed and weary, they smile and crush their children to their heaving chests, making unfullfillable promises. For who can bear to be forgotten? Come erbacce sulla roccia in attesa della falce (…) Queste sono le prigioni, questi i crimini che insegnano la vita con nuova violenza (…) Presto, prima del sole, sgomitano verso i cancelli nei loro spaventosi luoghi segreti, vedono la propria vita che gli si dipana di fronte (…) Ma quando arrivano a casa, stanchi e con occhi umidi, sorridono e si stringono i figli al petto ansante, facendo promesse inesaudibili. Perché chi può sopportare di venir dimenticato? Buona parte di questi versi sono parlati con voce metallica, come da un megafono, rimarcando così l’idea di omologazione oppressiva della società contemporanea. Su questi temi Bowie ritorna periodicamente anche nei dischi incisi dopo Let’s Dance, dalla fine degli anni ’80 fino a pochi anni fa – album quasi sempre di gran qualità, che le commemorazioni dello scorso gennaio hanno praticamente ignorato. Va menzionato, dall’album Tin Machine (1989) il brano “I can’t read” (“Non so leggere”), che tratta di deprivazione culturale in un mondo dove “money goes to money heaven / bodies go to body hell” (“ i soldi finiscono nel paradiso dei soldi / i corpi nell’inferno dei corpi”). Lo stesso LP contiene una cover di “Working class hero” (“Eroe della classe operaia”) di John Lennon (1970), inno anti-sistema cantato da Bowie con voce carica di rabbia: When they've tortured and scared you for twenty-odd years then they expect you to pick a career when you can't really function you're so full of fear (…) Keep you doped with religion and sex and TV and you think you're so clever and classless and free but you're still fucking peasants as far as I can see (…) There's room at the top they're telling you still but first you must learn how to smile as you kill Dopo che ti hanno torturato e terrorizzato per una ventina d’anni poi si aspettano che tu ti scelga una carriera mentre non riesci neanche a pensare tanto sei pieno di paura (…) Ti drogano di religione, sesso e TV e ti credi d’essere così furbo e oltre le classi e libero ma sei ancora un cazzo di bifolco, mi sembra (…) C’è ancora posto là in cima, ti continuano a dire Ma prima, mentre uccidi, devi imparare a sorridere Una diffusa alienazione sociale emerge anche in “Dead man walking” (“Morto che cammina”, 1997), un pezzo contaminato da sonorità drum’n’bass che martellano immagini come questa: an alien nation in therapy sliding naked, anew like a bad-tempered child on the rain-slicked streets una nazione aliena in terapia che scivola nuda, di nuovo come un bambino intrattabile per strade viscide di pioggia Due anni dopo, in “Seven”, riprende la figura del fratello maggiore Terry, sofferente di schizofrenia e suicida nel 1985, tornando così ad un altro tema per lui ricorrente, quello dei meccanismi sociali che riproducono la malattia mentale: I forgot what my brother said I forgot what he said I don’t regret anything at all I remember how he wept On a bridge of violent people I was small enough to cry I’ve got seven days to live my life or seven ways to die Ho scordato cosa diceva mio fratello ho scordato che diceva Non rimpiango davvero nulla mi ricordo come piangeva Sopra un ponte di gente violenta ero abbastanza piccolo da strillare Ho sette giorni per vivere la mia vita o sette giorni per morire L’attenzione di Bowie verso le vittime della Storia si può ritrovare, comunque, già prima del 1980. Quando ancora cantava ballate alla Bob Dylan, il pezzo “Little bombardier” (“Il piccolo artigliere”, 1967) narra di un reduce solo, spaesato e affamato di affetti: War made him a soldier, little Frankie Mear. Peace made him a loser, a little bombardier La Guerra lo fece un soldato piccolo Frankie Mear La pace lo fece un perdente, un piccolo artigliere Per sua grande gioia, diventa amico di due bambine, ma si farà cacciare perché sospettato di pedofilia: Leave them alone or we’ll get sore. We’ve had blokes like you in the station before Lasciale stare o cominceremo a seccarci. Ne abbiamo già avuti come te alla stazione di polizia. Pur puntando esplicitamente il dito contro l’autorità costituita, questa storia malinconica è musicata, scrive Pegg, con un “nostalgico valzer da fiera di paese (…) uno dei pochissimi brani di Bowie scritti in 3/4”. Il testo è ispirato al racconto “Uncle Ernest” (1959) di Alan Sillitoe, uno dei più felici narratori del nuovo realismo proletario nel secondo dopoguerra. In quanto a temi socio-politici, Bowie tocca spesso anche l’imperialismo statunitense e la natura repressiva delle religioni istituzionali (si veda ad esempio lo ‘scandaloso’ videoclip di “The next day”, 2013). Ma il Bowie che ho voluto ricordare qui è l'artista che non ha mai chiuso gli occhi di fronte alle ingiustizie, alla sofferenza degli ultimi. Potrà suonare paradossale, ma mi viene da pensare ad un altro grande cantore dei margini come Enzo Jannacci. Bowie torna spesso su ciò che in “Under pressure” (“Sotto pressione”, 1981) definisce “the terror of knowing what this world is about” (“il terrore di sapere di cosa è fatto questo mondo”), mentre Love dares you to care for the people in the streets the people on the edge of the night L’amore ti sfida a prenderti cura della gente per le strade la gente al margine della notte Certo, è difficile accostare i maglioni sudati di Jannacci al Bowie che ha creato e curato la propria immagine, cui il prestigioso Victoria and Albert Museum di Londra ha dedicato una mostra di grande successo nel 2013. E la voce di Jannacci, sempre apparentemente sul punto di esaurire il fiato, condivide poco con le virtuosità bowiane. Dietro ad entrambi vedo però una sensibilità comune, e un simile atteggiamento di insofferenza verso ogni inquadramento, ogni norma imposta dall’alto. Per me, i testi di Bowie hanno rappresentato l’inizio di una passione per la letteratura in lingua inglese, e per la natura indecifrabile, sfuggente e mai omologabile che è propria della poesia. Critchley nota che, a partire dal periodo berlinese, i suoi versi diventano meno intellegibili e narrativi, e che “colpiscono maggiormente quando sono più indiretti. Siamo noi a doverli completare con la nostra immaginazione, col nostro desiderio.” Continuo a citare Critchley anche perché mi ritrovo profondamente nel percorso del suo libro, purtroppo non ancora tradotto in italiano. Il volumetto si conclude con una frase che sottoscrivo, e che rappresenta il motivo per cui non ho ancora trovato il coraggio di ascoltare Blackstar, l’ultimo album uscito solo due giorni prima della morte: “Non voglio che Bowie finisca. Ma lo farà. E anche io.”
Bowie, il politico
DEANDREA, Pietro
2016-01-01
Abstract
"Mi sia concesso di cominciare con una confessione piuttosto imbarazzante: per tutta la mia vita nessuno mi ha dato piacere più grande di David Bowie. Certo, forse questo la dice lunga sulla qualità, della mia vita. Non fraintendetemi. Ci sono stati momenti belli, talvolta persino insieme ad altre persone. Ma per ciò che riguarda una gioia costante e prolungata attraverso i decenni, nulla si avvicina al piacere che mi ha dato Bowie." (Simon Critchley, Bowie) Quelli che non conoscono l’opera di Bowie, temo, avranno provato un po’ d’irritazione per la quantità di cose dette e scritte dopo la sua morte nel gennaio scorso. O perlomeno stupore, viste le innumerevoli sfaccettature per cui è stato ricordato. Come ha scritto giustamente Francesco Adinolfi su Il manifesto del 12 gennaio, “non c’è un solo Bowie, e ognuno ha il suo Bowie da piangere”. C’è ovviamente il Bowie che tra la fine dei ’60 e i primi anni ’70 porta in scena la libertà contro la soffocante pubblica morale, mescolando generi ed identità sessuali in canzoni e concerti, ostentando i suoi personaggi scandalosi per sbatterli in faccia a family day di ogni sorta. Lo scrittore Hanif Kureishi, per esempio, ricorda la canzone “Rebel rebel” (1974) come una spinta che lo porta a desiderare di andarsene dal monotono perbenismo del sud di Londra. Il filosofo Simon Critchley descrive l’impatto di “Rock’n’roll suicide” (1972), dove l’urlo “You’re not alone!” (“Non sei solo”!) diventa detonatore emotivo per una generazione di giovani a disagio con se stessi e con il mondo, spingendoli a cercare di diventare qualcos’altro – “qualcosa di più libero, più queer (traducibile con ‘eccentrico’, e anche ‘omosessuale’), più sincero, più aperto, e più eccitante.” Ma questo Bowie, l’icona del gender bending, è stracitato. Molto meno noto è il Bowie dall’animo irriducibilmente politico. Intendiamoci, anche dal punto di vista politico Bowie è stato molte cose. Nel 1975 rilascia alcune dichiarazioni di simpatia verso il nazismo, che saranno poi rettificate e (molto parzialmente) giustificate con la sua pericolosa dipendenza dalle droghe di quel periodo. Il clamore è amplificato da una fotografia in cui sembra fare il saluto romano a una folla di fan che lo attende a Victoria Station (ma osservando il filmato dell’evento su Internet, pare che il fotografo abbia preso lo scatto proprio nel momento in cui il braccio si tende in un normalissimo saluto). Si tratta di un aspetto delicato ancora da chiarire completamente, in cui anche critici raffinati come Critchley non si avventurano troppo. E che comunque ha finito per offuscare, secondo me, la figura di Bowie cantore degli ultimi e dei margini. Il nodo cruciale di questo suo aspetto è l’album Scary Monsters (1980), alla fine di un decennio segnato da una serie di album memorabili, dal glam rock alle sperimentazioni berlinesi – storicamente, la fine delle utopie e l’inizio del cosiddetto riflusso. Nel brano “Ashes to ashes” Bowie riprende il personaggio che l’aveva portato al successo, il Maggiore Tom, astronauta che in “Space oddity” (1969) celebrava l’allunaggio ma al contempo si perdeva stranamente a galleggiare nello spazio. Seguendo una parabola analoga agli ideali bruciati di quel periodo, nel 1980 Major Tom ricompare travolto dalle droghe pesanti, schiavo dei mostri che lo perseguitano nello spazio: I want an axe to break the ice, I want to come down right now Ashes to ashes, funk to funky We know Major Tom’s a junkie strung out in heaven’s high hitting an all-time low Voglio un’ascia per rompere il ghiaccio, voglio venir giù subito Cenere alla cenere, funk al funky Lo sappiamo che Major Tom è un tossico sperso nell’alto dei cieli caduto in una depressione storica Ma anche la realtà in cui Major Tom desidera tornare non promette nulla di buono. In Scary Monsters si manifesta uno dei punti più alti della critica socio-politica nei testi di Bowie, che assume toni quasi profetici. Mi riferisco alla canzone che apre l’album, “It’s no game (no. 1)”: Silhouettes and shadows watch the revolution No more free steps to heaven and it’s no game (…) Documentaries on refugees couples ‘gainst the target (…) Draw the blinds on yesterday and it’s all so much scarier Put a bullet in my brain and it makes all the papers Profili e ombre guardano la rivoluzione Niente più passi facili verso il paradiso e non è un gioco (…) Documentari su rifugiati coppie nel mirino (…) Chiudi la finestra sul passato ed è tutto più spaventoso Sparami un colpo in testa e ne parleranno tutti i giornali Qui Bowie sembra svelare quella che sarà la faccia oscura degli anni ’80 e oltre: la questione dei rifugiati e delle vittime civili dei conflitti (come suonano profetici quei due versi…), l’oblio degli ideali del passato, lo sguardo onnipresente ma banalizzante dei mass media. E’ importante ascoltare “It’s no game (no. 1)” anche perché Bowie canta questa canzone a squarciagola, a voce quasi stridula, come se lo stessero torturando; l’insieme è reso più complesso dall’alternanza con una voce femminile che canta in giapponese una traduzione del testo, in tono aggressivo. Secondo Critchley, “il genio di Bowie risiede nell’armonizzare minuziosamente parole e musica attraverso il mezzo della voce”. I versi finali della canzone introducono poi un riferimento più esplicitamente politico, forse riferendosi alla polemica menzionata sopra: So where’s the moral? People have their fingers broken To be insulted by these fascists – it’s so degrading And it’s no game E allora dov’è la morale? La gente ha le dita spezzate Venir insultati da ’sti fascisti – è così degradante E non è un gioco La voce di Bowie si contorce soprattutto quando pronuncia il titolo della canzone, “non è un gioco”: il dramma della ‘fine delle ideologie’ sta nel poter non prendere più nulla sul serio, neanche le grandi tragedie. C’è una coincidenza curiosa, a questo proposito. L’anno seguente Giorgio Gaber mette in scena il recital Anni affollati, e nel pezzo parlato “Il presente” offre (ovviamente con Sandro Luporini) una caustica riflessione sul nuovo clima dei primi anni ’80, dove i più bravi e geniali riescono a togliersi di dosso la pesantezza di qualcosa che ingombra per dedicarsi allo ‘smitizzante’. Perché di fronte all’idiozia dei vecchi moralisti, preferisco vedere l’uomo di cultura che si fa fotografare nudo su un divano a fiori. Eh sì, per questa sua capacità di saper vivere il gioco. Sto parlando insomma di quelli veramente colti, che con sottile ironia hanno riscoperto… l’effimero. Ecco che cos’è il presente: l’effimero. E devo dire che per della gente come noi, che non crede più a niente, questo è perfetto. (…) La cosa più intelligente da fare è quella di giocare d’astuzia con i segnali del tempo. Ma attenzione, perché tra l’avere la sensazione che il mondo sia una cosa poco seria, e il muovercisi dentro perfettamente a proprio agio, esiste la stessa differenza che c’è tra l’avere il senso del comico ed essere ridicoli… La canzone di Bowie non finisce qui, perché Scary Monsters ha una struttura circolare e si chiude con “It’s no game (no. 2)” (“Non è un gioco, parte seconda”), dove viene riproposto lo stesso motivo – o quasi. Questa versione accentua la critica sociale (e la visionarietà profetica) aggiungendo una strofa finale sullo sfruttamento del lavoro minorile: Children ‘round the world put camel shit on the walls Making carpets on treadmills, or garbage sorting And it’s no game Bambini in tutto il mondo mettono cacca di cammello sui muri Fanno tappeti su macchinari, o frugano in discariche E non è un gioco Ma soprattutto, i versi di questa “parte seconda” sono cantati in modo radicalmente diverso, con voce lenta, calda, modulata, quasi da crooner in stile Frank Sinatra, quasi a voler dire: guardate che anche i miei pezzi apparentemente più commerciali possono essere qualcosa di più di semplici canzoni orecchiabili. E’ una caratteristica dei suoi testi che viene colta anche dalla genialità sregolata di Lars Von Trier, il cui durissimo film Dogville (2003), sulla brutalità del sogno americano, si conclude con la scena del massacro di un intero villaggio e uno stacco improvviso sui titoli di coda: una sequenza di immagini di povertà e degrado statunitense con in sottofondo il pezzo “Young Americans” (1975), dal ritmo allegro ma con un sottotesto che accenna alla sterilizzante massificazione degli individui: We live for just these twenty years, do we have to die for the fifty more? Viviamo solo per questi vent’anni, dobbiamo morire per altri cinquanta? Questa ambivalenza è riscontrabile soprattutto nei dischi immediatamente successivi a Scary Monsters, quelli segnati da un disimpegno che per la prima volta fanno diventare Bowie un fenomeno commerciale mainstream, e che molti fan ancora rifiutano. Mi riferisco innanzi tutto a Let’s Dance (1983), ovviamente, ricordando il videoclip della canzone omonima che mette in primo piano la condizione degli aborigeni australiani; come scrive Nicholas Pegg nel suo enciclopedico The Complete David Bowie, “prendendo spunto solo marginalmente dal testo della canzone per sposare la causa dei diritti degli aborigeni, il video costituisce il primo (sic) sostanziale esempio del ruolo da militante sociopolitico che Bowie cominciava a ritagliarsi negli anni ’80.” Sempre in Let’s Dance, il brano “Ricochet” (“Pallottola di rimbalzo”) è pervaso da un senso di totale sacrificabilità delle vite umane; come in “It’s no game”, i versi sembrano già descrivere il lato oscuro della globalizzazione neoliberista: Like weeds on a rock face waiting for the scythe (…) These are the prisons, these are the crimes teaching life in a violent new way (…) Early, before the sun, they struggle off to the gates in their secret fearful places, they see their lives unraveling before them (…) But when they get home, damp-eyed and weary, they smile and crush their children to their heaving chests, making unfullfillable promises. For who can bear to be forgotten? Come erbacce sulla roccia in attesa della falce (…) Queste sono le prigioni, questi i crimini che insegnano la vita con nuova violenza (…) Presto, prima del sole, sgomitano verso i cancelli nei loro spaventosi luoghi segreti, vedono la propria vita che gli si dipana di fronte (…) Ma quando arrivano a casa, stanchi e con occhi umidi, sorridono e si stringono i figli al petto ansante, facendo promesse inesaudibili. Perché chi può sopportare di venir dimenticato? Buona parte di questi versi sono parlati con voce metallica, come da un megafono, rimarcando così l’idea di omologazione oppressiva della società contemporanea. Su questi temi Bowie ritorna periodicamente anche nei dischi incisi dopo Let’s Dance, dalla fine degli anni ’80 fino a pochi anni fa – album quasi sempre di gran qualità, che le commemorazioni dello scorso gennaio hanno praticamente ignorato. Va menzionato, dall’album Tin Machine (1989) il brano “I can’t read” (“Non so leggere”), che tratta di deprivazione culturale in un mondo dove “money goes to money heaven / bodies go to body hell” (“ i soldi finiscono nel paradiso dei soldi / i corpi nell’inferno dei corpi”). Lo stesso LP contiene una cover di “Working class hero” (“Eroe della classe operaia”) di John Lennon (1970), inno anti-sistema cantato da Bowie con voce carica di rabbia: When they've tortured and scared you for twenty-odd years then they expect you to pick a career when you can't really function you're so full of fear (…) Keep you doped with religion and sex and TV and you think you're so clever and classless and free but you're still fucking peasants as far as I can see (…) There's room at the top they're telling you still but first you must learn how to smile as you kill Dopo che ti hanno torturato e terrorizzato per una ventina d’anni poi si aspettano che tu ti scelga una carriera mentre non riesci neanche a pensare tanto sei pieno di paura (…) Ti drogano di religione, sesso e TV e ti credi d’essere così furbo e oltre le classi e libero ma sei ancora un cazzo di bifolco, mi sembra (…) C’è ancora posto là in cima, ti continuano a dire Ma prima, mentre uccidi, devi imparare a sorridere Una diffusa alienazione sociale emerge anche in “Dead man walking” (“Morto che cammina”, 1997), un pezzo contaminato da sonorità drum’n’bass che martellano immagini come questa: an alien nation in therapy sliding naked, anew like a bad-tempered child on the rain-slicked streets una nazione aliena in terapia che scivola nuda, di nuovo come un bambino intrattabile per strade viscide di pioggia Due anni dopo, in “Seven”, riprende la figura del fratello maggiore Terry, sofferente di schizofrenia e suicida nel 1985, tornando così ad un altro tema per lui ricorrente, quello dei meccanismi sociali che riproducono la malattia mentale: I forgot what my brother said I forgot what he said I don’t regret anything at all I remember how he wept On a bridge of violent people I was small enough to cry I’ve got seven days to live my life or seven ways to die Ho scordato cosa diceva mio fratello ho scordato che diceva Non rimpiango davvero nulla mi ricordo come piangeva Sopra un ponte di gente violenta ero abbastanza piccolo da strillare Ho sette giorni per vivere la mia vita o sette giorni per morire L’attenzione di Bowie verso le vittime della Storia si può ritrovare, comunque, già prima del 1980. Quando ancora cantava ballate alla Bob Dylan, il pezzo “Little bombardier” (“Il piccolo artigliere”, 1967) narra di un reduce solo, spaesato e affamato di affetti: War made him a soldier, little Frankie Mear. Peace made him a loser, a little bombardier La Guerra lo fece un soldato piccolo Frankie Mear La pace lo fece un perdente, un piccolo artigliere Per sua grande gioia, diventa amico di due bambine, ma si farà cacciare perché sospettato di pedofilia: Leave them alone or we’ll get sore. We’ve had blokes like you in the station before Lasciale stare o cominceremo a seccarci. Ne abbiamo già avuti come te alla stazione di polizia. Pur puntando esplicitamente il dito contro l’autorità costituita, questa storia malinconica è musicata, scrive Pegg, con un “nostalgico valzer da fiera di paese (…) uno dei pochissimi brani di Bowie scritti in 3/4”. Il testo è ispirato al racconto “Uncle Ernest” (1959) di Alan Sillitoe, uno dei più felici narratori del nuovo realismo proletario nel secondo dopoguerra. In quanto a temi socio-politici, Bowie tocca spesso anche l’imperialismo statunitense e la natura repressiva delle religioni istituzionali (si veda ad esempio lo ‘scandaloso’ videoclip di “The next day”, 2013). Ma il Bowie che ho voluto ricordare qui è l'artista che non ha mai chiuso gli occhi di fronte alle ingiustizie, alla sofferenza degli ultimi. Potrà suonare paradossale, ma mi viene da pensare ad un altro grande cantore dei margini come Enzo Jannacci. Bowie torna spesso su ciò che in “Under pressure” (“Sotto pressione”, 1981) definisce “the terror of knowing what this world is about” (“il terrore di sapere di cosa è fatto questo mondo”), mentre Love dares you to care for the people in the streets the people on the edge of the night L’amore ti sfida a prenderti cura della gente per le strade la gente al margine della notte Certo, è difficile accostare i maglioni sudati di Jannacci al Bowie che ha creato e curato la propria immagine, cui il prestigioso Victoria and Albert Museum di Londra ha dedicato una mostra di grande successo nel 2013. E la voce di Jannacci, sempre apparentemente sul punto di esaurire il fiato, condivide poco con le virtuosità bowiane. Dietro ad entrambi vedo però una sensibilità comune, e un simile atteggiamento di insofferenza verso ogni inquadramento, ogni norma imposta dall’alto. Per me, i testi di Bowie hanno rappresentato l’inizio di una passione per la letteratura in lingua inglese, e per la natura indecifrabile, sfuggente e mai omologabile che è propria della poesia. Critchley nota che, a partire dal periodo berlinese, i suoi versi diventano meno intellegibili e narrativi, e che “colpiscono maggiormente quando sono più indiretti. Siamo noi a doverli completare con la nostra immaginazione, col nostro desiderio.” Continuo a citare Critchley anche perché mi ritrovo profondamente nel percorso del suo libro, purtroppo non ancora tradotto in italiano. Il volumetto si conclude con una frase che sottoscrivo, e che rappresenta il motivo per cui non ho ancora trovato il coraggio di ascoltare Blackstar, l’ultimo album uscito solo due giorni prima della morte: “Non voglio che Bowie finisca. Ma lo farà. E anche io.”| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
BowieDeandreaStraniero.docx
Accesso aperto
Descrizione: Versione pre-print, poi caricata dall'editore sul sito della rivista alla pagina http://lostraniero.net/2222-2/
Tipo di file:
PREPRINT (PRIMA BOZZA)
Dimensione
18.38 kB
Formato
Microsoft Word XML
|
18.38 kB | Microsoft Word XML | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.