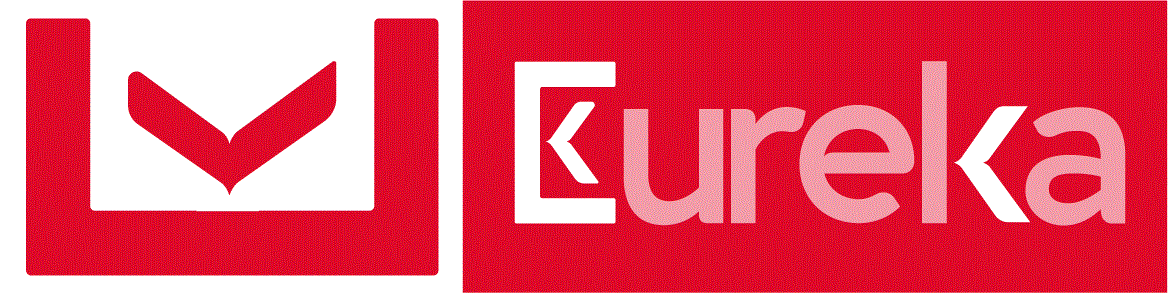“Gli oppressi e gli sfruttati della terra ribadiscono la loro sfida: libertà dal furto. Ma l’arma più grande […] scatenata dall’imperialismo contro questa sfida collettiva è la bomba culturale”. Il keniota Ngũgĩ wa Thiong’o (nato nel 1938) definisce con chiarezza il bersaglio di questo suo volume finalmente in edizione italiana, Decolonizzare la mente: La politica della lingua nella letteratura africana (Jaca Book, traduzione di Maria Teresa Carbone, pp. 126, € 14). La “bomba” in questione è l’assoggettamento culturale operato da colonialismo e neocolonialismo: “una bomba che annulla la fiducia di un popolo nel proprio nome, nella propria lingua, […] nelle proprie capacità e in definitiva in se stesso.” Romanziere, drammaturgo e saggista, uno dei padri della letteratura africana anglofona ed una delle sue voci più radicali, Ngũgĩ è noto come instancabile spirito critico contro i regimi di un’Africa solo apparentemente liberata, da cui ha subito carcere, esilio e violenze fisiche. Il nodo centrale di questa raccolta di saggi datata 1986, è la domanda delle domande per gli studi postcoloniali: come immaginare una decolonizzazione reale, dopo secoli di violenza culturale e psicologica? Il sottotitolo del volume allude alla risposta: attraverso la rivalutazione delle lingue africane in luogo di quelle europee. L’autore parte dallo storico convegno di Makerere del 1962, dove gli intellettuali africani davano per scontato lo scrivere in francese, inglese o portoghese. Per dimostrare come ciò non fosse assolutamente un fatto dovuto, Ngũgĩ torna alla sua infanzia (narrata anche in Sogni in tempo di guerra, Jaca 2012), immersa nella cultura e lingua gikũyũ di espressione orale ma anche scritta, grazie alla presenza di scuole dove l’apprendimento era in lingue locali. Con la lotta di liberazione dell’esercito Mau Mau e la proclamazione dello stato d’emergenza (1952), l’inglese divenne la lingua obbligatoria dell’apprendimento, “unità di misura dell’intelligenza e dell’abilità”, in un clima orwelliano di delazioni tra studenti e punizioni corporali per chi fosse sorpreso a parlare gikũyũ. Qui Ngũgĩ cita le parole del romanziere C.H. Kane: “Il cannone domina i corpi, la scuola incanta le anime.” Si spezzava così l’armonia tra ambiente e lingua, radice dell’alienazione coloniale e di una “dissociazione della sensibilità” per cui apprendere “divenne così una attività cerebrale e non una esperienza vissuta a livello emotivo.” Per un’intera cultura ciò creava un fenomeno che Ngũgĩ descrive come decapitazione culturale, quasi una zombizzazione collettiva, “una società di teste senza corpo e di corpi senza testa.” In una prospettiva molto autobiografica (talvolta percorsa da una sottile vena narcisistica), l’autore offre il proprio vissuto personale come esemplare di una possibilità di resistenza a questo fenomeno. La presa di coscienza linguistica si lega a un orientamento esplicitamente marxista, e alla profonda disillusione di fronte ai fallimenti delle élite borghesi neocoloniali: come trovare il modo di parlare a contadini ed operai e di spingerli verso un rinnovamento sociale, se non usando una lingua per loro non aliena? Coerentemente con gli obiettivi del volume, la risposta si sviluppa in una scrittura argomentata in maniera limpida e chiara, libera da vezzi espressionistici. Romanziere già affermato in lingua inglese e accademico a Nairobi, nel 1977 Ngũgĩ si mette in gioco con l’esperienza del teatro di comunità di Kamĩrĩĩthũ: struttura collegata alla vita sociale, oltre che spazio architettonicamente aperto per permettere a ognuno di contribuire all’organizzazione dello spettacolo con proprie narrazioni, osservazioni linguistiche (peccato che l’autore non scenda nel dettaglio) e discussioni: un democratico “apprendimento continuo” per tutti, autore incluso. Qui il debito verso lo “spazio vuoto” di Brook e il “teatro degli oppressi” di Boal è dichiarato, ma viene da pensare anche alle creazioni collettive di certe compagnie britanniche della seconda metà del ‘900. Il prodotto finale, di grande successo, è uno spettacolo in lingua gikũyũ di matrice tradizionale, dove la parola si accompagna a canti e danze. Ma viene stroncato sul nascere dal regime dittatoriale, che bandisce le attività teatrali del centro e successivamente lo rade al suolo, perseguitando e incarcerando gli intellettuali coinvolti nel progetto. Isolato in carcere nel corso del 1978, con questo chiaro esempio di quanto un’arte popolare possa essere pericolosa perché efficace, Ngũgĩ si sposta sulla narrativa con un romanzo in gikũyũ, composto su rotoli di carta igienica assai ruvida (“un modo per punire i detenuti”, ma “quello che andava male per il corpo andava bene per la penna”). Come lo spettacolo teatrale, anch’esso trova ispirazione nei generi letterari dell’oratura (letteratura orale), e in maniera analoga viene trasmesso oralmente: letto nelle case e nei bar, a gruppi, e distribuito attraverso canali non ufficiali. Da qui Ngũgĩ comincerà ad autotradursi dal gikũyũ all’inglese, muovendosi tra le due lingue come faceva il compianto André Brink fra inglese a afrikaans. L’ultimo capitolo affronta la questione della lingua da una prospettiva più sociale, partendo dal dibattito del 1968 sul ri-orientamento dei dipartimenti di letteratura delle università del Kenya, al tempo ancora dominati dal canone britannico. Ci si sposta poi sul più ampio dibattito nazionale del 1974 riguardo al sistema scolastico, viziato da analogo eurocentrismo. Le proposte di rinnovamento si fondavano sul ruolo di letterature orali e scritte nel loro contesto panafricano e della diaspora dei popoli neri, rigettando l’idea di “sostituire lo sciovinismo britannico coloniale dei piani di studio esistenti con uno sciovinismo nazionale”. Questo è ciò che Ngũgĩ intende con Spostare il centro del mondo, titolo di un altro suo volume di saggi (Meltemi 2000). Anche i sostenitori di questo rinnovamento, ricorda l’autore, venivano bollati come sovversivi e perseguitati dal regime, e non a caso il volume si chiude con una rivendicazione filosofica e politica della sua proposta. Rivalutare il ruolo di culture a lingue africane è condizione necessaria, ma non sufficiente per una vera decolonizzazione, se ciò “non veicola la lotta antimperialista dei nostri popoli”. Brecht e Marx diventano ispiratori di un richiamo a prendere posizione, all’azione: “l’appello a riscoprire e a riprendere le nostre lingue è un appello a rigenerarci”, “a riscoprire il vero linguaggio del genere umano: il linguaggio della lotta”. Per alcuni sembrerà ruggine ideologica, ma sembra di risentire Arundhati Roy quando sprona a lottare contro il neoliberismo dicendo proprio “fighting is fun” (“lottare è divertente”). Quanto è ancora attuale Decolonizzare la mente? Tantissimo, secondo la breve nota della curatrice (ma un libro così importante avrebbe meritato una prefazione più articolata); credo sia vero, perché rileggere il libro con le lenti dell’attualità stimola una serie di riflessioni. Ad esempio, la rivalutazione delle lingue africane è solida e convincente, ma richiede investimenti culturali di ampio respiro: come pensare di attuarla sotto il tallone della globalizzazione? E, sempre sostituendo “imperialismo” con “globalizzazione”, si resta inevitabilmente colpiti quando Ngũgĩ scrive che “l’imperialismo è totalizzante: ha conseguenze politiche, militari, culturali, e psicologiche per tutta la popolazione del mondo. Potrebbe perfino condurre all’olocausto.”
Ngugi: Nelle lingue africane suona meglio la lotta
DEANDREA, Pietro
2015-01-01
Abstract
“Gli oppressi e gli sfruttati della terra ribadiscono la loro sfida: libertà dal furto. Ma l’arma più grande […] scatenata dall’imperialismo contro questa sfida collettiva è la bomba culturale”. Il keniota Ngũgĩ wa Thiong’o (nato nel 1938) definisce con chiarezza il bersaglio di questo suo volume finalmente in edizione italiana, Decolonizzare la mente: La politica della lingua nella letteratura africana (Jaca Book, traduzione di Maria Teresa Carbone, pp. 126, € 14). La “bomba” in questione è l’assoggettamento culturale operato da colonialismo e neocolonialismo: “una bomba che annulla la fiducia di un popolo nel proprio nome, nella propria lingua, […] nelle proprie capacità e in definitiva in se stesso.” Romanziere, drammaturgo e saggista, uno dei padri della letteratura africana anglofona ed una delle sue voci più radicali, Ngũgĩ è noto come instancabile spirito critico contro i regimi di un’Africa solo apparentemente liberata, da cui ha subito carcere, esilio e violenze fisiche. Il nodo centrale di questa raccolta di saggi datata 1986, è la domanda delle domande per gli studi postcoloniali: come immaginare una decolonizzazione reale, dopo secoli di violenza culturale e psicologica? Il sottotitolo del volume allude alla risposta: attraverso la rivalutazione delle lingue africane in luogo di quelle europee. L’autore parte dallo storico convegno di Makerere del 1962, dove gli intellettuali africani davano per scontato lo scrivere in francese, inglese o portoghese. Per dimostrare come ciò non fosse assolutamente un fatto dovuto, Ngũgĩ torna alla sua infanzia (narrata anche in Sogni in tempo di guerra, Jaca 2012), immersa nella cultura e lingua gikũyũ di espressione orale ma anche scritta, grazie alla presenza di scuole dove l’apprendimento era in lingue locali. Con la lotta di liberazione dell’esercito Mau Mau e la proclamazione dello stato d’emergenza (1952), l’inglese divenne la lingua obbligatoria dell’apprendimento, “unità di misura dell’intelligenza e dell’abilità”, in un clima orwelliano di delazioni tra studenti e punizioni corporali per chi fosse sorpreso a parlare gikũyũ. Qui Ngũgĩ cita le parole del romanziere C.H. Kane: “Il cannone domina i corpi, la scuola incanta le anime.” Si spezzava così l’armonia tra ambiente e lingua, radice dell’alienazione coloniale e di una “dissociazione della sensibilità” per cui apprendere “divenne così una attività cerebrale e non una esperienza vissuta a livello emotivo.” Per un’intera cultura ciò creava un fenomeno che Ngũgĩ descrive come decapitazione culturale, quasi una zombizzazione collettiva, “una società di teste senza corpo e di corpi senza testa.” In una prospettiva molto autobiografica (talvolta percorsa da una sottile vena narcisistica), l’autore offre il proprio vissuto personale come esemplare di una possibilità di resistenza a questo fenomeno. La presa di coscienza linguistica si lega a un orientamento esplicitamente marxista, e alla profonda disillusione di fronte ai fallimenti delle élite borghesi neocoloniali: come trovare il modo di parlare a contadini ed operai e di spingerli verso un rinnovamento sociale, se non usando una lingua per loro non aliena? Coerentemente con gli obiettivi del volume, la risposta si sviluppa in una scrittura argomentata in maniera limpida e chiara, libera da vezzi espressionistici. Romanziere già affermato in lingua inglese e accademico a Nairobi, nel 1977 Ngũgĩ si mette in gioco con l’esperienza del teatro di comunità di Kamĩrĩĩthũ: struttura collegata alla vita sociale, oltre che spazio architettonicamente aperto per permettere a ognuno di contribuire all’organizzazione dello spettacolo con proprie narrazioni, osservazioni linguistiche (peccato che l’autore non scenda nel dettaglio) e discussioni: un democratico “apprendimento continuo” per tutti, autore incluso. Qui il debito verso lo “spazio vuoto” di Brook e il “teatro degli oppressi” di Boal è dichiarato, ma viene da pensare anche alle creazioni collettive di certe compagnie britanniche della seconda metà del ‘900. Il prodotto finale, di grande successo, è uno spettacolo in lingua gikũyũ di matrice tradizionale, dove la parola si accompagna a canti e danze. Ma viene stroncato sul nascere dal regime dittatoriale, che bandisce le attività teatrali del centro e successivamente lo rade al suolo, perseguitando e incarcerando gli intellettuali coinvolti nel progetto. Isolato in carcere nel corso del 1978, con questo chiaro esempio di quanto un’arte popolare possa essere pericolosa perché efficace, Ngũgĩ si sposta sulla narrativa con un romanzo in gikũyũ, composto su rotoli di carta igienica assai ruvida (“un modo per punire i detenuti”, ma “quello che andava male per il corpo andava bene per la penna”). Come lo spettacolo teatrale, anch’esso trova ispirazione nei generi letterari dell’oratura (letteratura orale), e in maniera analoga viene trasmesso oralmente: letto nelle case e nei bar, a gruppi, e distribuito attraverso canali non ufficiali. Da qui Ngũgĩ comincerà ad autotradursi dal gikũyũ all’inglese, muovendosi tra le due lingue come faceva il compianto André Brink fra inglese a afrikaans. L’ultimo capitolo affronta la questione della lingua da una prospettiva più sociale, partendo dal dibattito del 1968 sul ri-orientamento dei dipartimenti di letteratura delle università del Kenya, al tempo ancora dominati dal canone britannico. Ci si sposta poi sul più ampio dibattito nazionale del 1974 riguardo al sistema scolastico, viziato da analogo eurocentrismo. Le proposte di rinnovamento si fondavano sul ruolo di letterature orali e scritte nel loro contesto panafricano e della diaspora dei popoli neri, rigettando l’idea di “sostituire lo sciovinismo britannico coloniale dei piani di studio esistenti con uno sciovinismo nazionale”. Questo è ciò che Ngũgĩ intende con Spostare il centro del mondo, titolo di un altro suo volume di saggi (Meltemi 2000). Anche i sostenitori di questo rinnovamento, ricorda l’autore, venivano bollati come sovversivi e perseguitati dal regime, e non a caso il volume si chiude con una rivendicazione filosofica e politica della sua proposta. Rivalutare il ruolo di culture a lingue africane è condizione necessaria, ma non sufficiente per una vera decolonizzazione, se ciò “non veicola la lotta antimperialista dei nostri popoli”. Brecht e Marx diventano ispiratori di un richiamo a prendere posizione, all’azione: “l’appello a riscoprire e a riprendere le nostre lingue è un appello a rigenerarci”, “a riscoprire il vero linguaggio del genere umano: il linguaggio della lotta”. Per alcuni sembrerà ruggine ideologica, ma sembra di risentire Arundhati Roy quando sprona a lottare contro il neoliberismo dicendo proprio “fighting is fun” (“lottare è divertente”). Quanto è ancora attuale Decolonizzare la mente? Tantissimo, secondo la breve nota della curatrice (ma un libro così importante avrebbe meritato una prefazione più articolata); credo sia vero, perché rileggere il libro con le lenti dell’attualità stimola una serie di riflessioni. Ad esempio, la rivalutazione delle lingue africane è solida e convincente, ma richiede investimenti culturali di ampio respiro: come pensare di attuarla sotto il tallone della globalizzazione? E, sempre sostituendo “imperialismo” con “globalizzazione”, si resta inevitabilmente colpiti quando Ngũgĩ scrive che “l’imperialismo è totalizzante: ha conseguenze politiche, militari, culturali, e psicologiche per tutta la popolazione del mondo. Potrebbe perfino condurre all’olocausto.”I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.