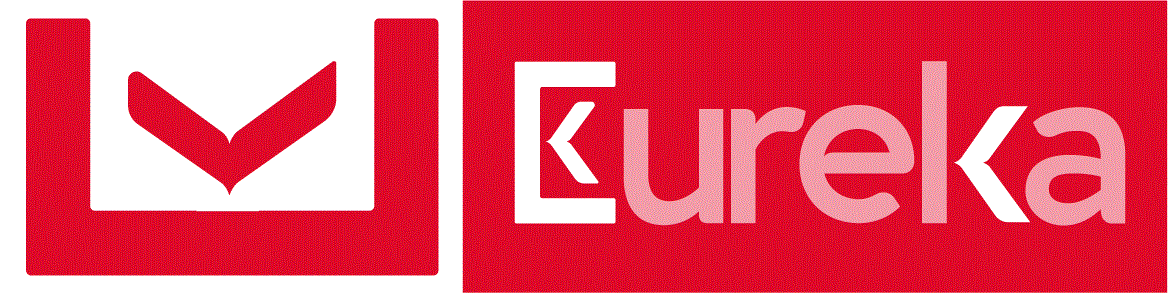Mia Alvar, Famiglie ombra, ed. orig. 2015, trad. dall’inglese di Gioia Guerzoni, pp. 456, € 18, Racconti, Roma 2017 Nei vecchi cine-melodrammi in lingua tagalog, il kontrabida è il cattivo, ’o malamente, l’antagonista moro e baffuto dell’eroe biondo. Il primo racconto di questa raccolta si intitola Kontrabida perché il protagonista torna dagli Stati Uniti nelle Filippine per rivedere il padre, violento ed autoritario capofamiglia con un cancro in fase terminale. La presenza del genitore è talmente opprimente da aver reso il figlio un perfezionista ossessivo che però, stavolta, ha infranto la legge portando con sé illegalmente un potente farmaco contro il dolore. Tra questi due kontrabida la madre, che ha sempre servito passivamente, fatica senza sosta: “la sua santità era un’idea che amavo più di quanto avessi mai odiato mio padre.” Le donne schiacciate dagli ingranaggi patriarcali sono una costante di questi racconti, ma sono anche figure che a un certo momento rialzano il capo con “piccoli ammutinamenti” rigogliosi come la copertina disegnata da Elisa Talentino, e in questo modo danno una svolta alle narrazioni. Esmeralda mantiene una allargatissima famiglia e un fratello delinquente facendo le pulizie notturne negli uffici delle Torri Gemelle; poi conquista uno spazio tutto per sé grazie a una relazione clandestina con il manager John, e non esita ad affrontare le esplosioni dell’11 settembre per raggiungerlo. Milagros è infermiera ed attivista politica nelle Filippine del dittatore Marcos (uno “zoo corrotto e trasandato”): travolta dalla depressione quando il regime le uccide il figlio dodicenne, non accetta più neanche il marito, irriducibile giornalista politico: “Sono tutti uguali per lei ormai, questa confraternita di uomini, che trasmettono in televisione i loro scioperi della fame, che (…) mangiano il riso senza chiedersi chi l’ha cucinato e come è arrivato a tavola. Che chiamano i figli come loro ma non si preoccupano mai delle loro unghie.” Per non parlare della madre in Kontrabida, appunto, che compie un gesto tanto impensabile quanto beffardo, lasciando il protagonista disposto a fare di tutto “solo perché lei rimanesse la madre che conoscevo, non una sconosciuta che rideva nell’oscurità.” Queste sono spesso storie di balikbayan, lavoratori migranti che partono e tornano. Balikbayan era anche il titolo di una bella raccolta di racconti filippini anglofoni tradotta da Feltrinelli nel 1999, precursori in Italia di nomi come il poeta Gémino Abad (Dove le parole non si spezzano, Ensemble 2015) o del regista Lav Diaz (Leone d’Oro a Venezia 2016). Gli emigrati di Mia Alvar fanno parte di “famiglie ombra” in quanto vedono le loro relazioni disgregarsi lentamente, le loro vite sfibrate dal lavoro e dalla lontananza negli Stati Uniti o nelle severe monarchie petrolifere del Golfo: “Vivevamo come contadini ai piedi di un vulcano, timorosi di offendere gli dèi che governavano i nostri raccolti e la nostra ricchezza.” Ma se quest’opera prima ha ricevuto il premio PEN /Robert W. Bingham, non è solo per la sua denuncia sociale o di genere, anzi. La scrittura di Alvar brilla soprattutto quando dispiega la lezione calviniana della leggerezza, che diventa magistrale in Un contratto all’estero, dove una ragazza del ghetto cede al fascino di un circolo universitario bohémien e disimpegnato, “sentendomi un po’ come un’intrusa al tè del Cappellaio Matto (…) ad analizzare paragrafi e punti di vista quasi ne dipendesse la scoperta di una cura per il cancro.” E, ovviamente, trova la sua libertà nella scrittura.
Piccoli ammutinamenti
Pietro Deandrea
2017-01-01
Abstract
Mia Alvar, Famiglie ombra, ed. orig. 2015, trad. dall’inglese di Gioia Guerzoni, pp. 456, € 18, Racconti, Roma 2017 Nei vecchi cine-melodrammi in lingua tagalog, il kontrabida è il cattivo, ’o malamente, l’antagonista moro e baffuto dell’eroe biondo. Il primo racconto di questa raccolta si intitola Kontrabida perché il protagonista torna dagli Stati Uniti nelle Filippine per rivedere il padre, violento ed autoritario capofamiglia con un cancro in fase terminale. La presenza del genitore è talmente opprimente da aver reso il figlio un perfezionista ossessivo che però, stavolta, ha infranto la legge portando con sé illegalmente un potente farmaco contro il dolore. Tra questi due kontrabida la madre, che ha sempre servito passivamente, fatica senza sosta: “la sua santità era un’idea che amavo più di quanto avessi mai odiato mio padre.” Le donne schiacciate dagli ingranaggi patriarcali sono una costante di questi racconti, ma sono anche figure che a un certo momento rialzano il capo con “piccoli ammutinamenti” rigogliosi come la copertina disegnata da Elisa Talentino, e in questo modo danno una svolta alle narrazioni. Esmeralda mantiene una allargatissima famiglia e un fratello delinquente facendo le pulizie notturne negli uffici delle Torri Gemelle; poi conquista uno spazio tutto per sé grazie a una relazione clandestina con il manager John, e non esita ad affrontare le esplosioni dell’11 settembre per raggiungerlo. Milagros è infermiera ed attivista politica nelle Filippine del dittatore Marcos (uno “zoo corrotto e trasandato”): travolta dalla depressione quando il regime le uccide il figlio dodicenne, non accetta più neanche il marito, irriducibile giornalista politico: “Sono tutti uguali per lei ormai, questa confraternita di uomini, che trasmettono in televisione i loro scioperi della fame, che (…) mangiano il riso senza chiedersi chi l’ha cucinato e come è arrivato a tavola. Che chiamano i figli come loro ma non si preoccupano mai delle loro unghie.” Per non parlare della madre in Kontrabida, appunto, che compie un gesto tanto impensabile quanto beffardo, lasciando il protagonista disposto a fare di tutto “solo perché lei rimanesse la madre che conoscevo, non una sconosciuta che rideva nell’oscurità.” Queste sono spesso storie di balikbayan, lavoratori migranti che partono e tornano. Balikbayan era anche il titolo di una bella raccolta di racconti filippini anglofoni tradotta da Feltrinelli nel 1999, precursori in Italia di nomi come il poeta Gémino Abad (Dove le parole non si spezzano, Ensemble 2015) o del regista Lav Diaz (Leone d’Oro a Venezia 2016). Gli emigrati di Mia Alvar fanno parte di “famiglie ombra” in quanto vedono le loro relazioni disgregarsi lentamente, le loro vite sfibrate dal lavoro e dalla lontananza negli Stati Uniti o nelle severe monarchie petrolifere del Golfo: “Vivevamo come contadini ai piedi di un vulcano, timorosi di offendere gli dèi che governavano i nostri raccolti e la nostra ricchezza.” Ma se quest’opera prima ha ricevuto il premio PEN /Robert W. Bingham, non è solo per la sua denuncia sociale o di genere, anzi. La scrittura di Alvar brilla soprattutto quando dispiega la lezione calviniana della leggerezza, che diventa magistrale in Un contratto all’estero, dove una ragazza del ghetto cede al fascino di un circolo universitario bohémien e disimpegnato, “sentendomi un po’ come un’intrusa al tè del Cappellaio Matto (…) ad analizzare paragrafi e punti di vista quasi ne dipendesse la scoperta di una cura per il cancro.” E, ovviamente, trova la sua libertà nella scrittura.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.