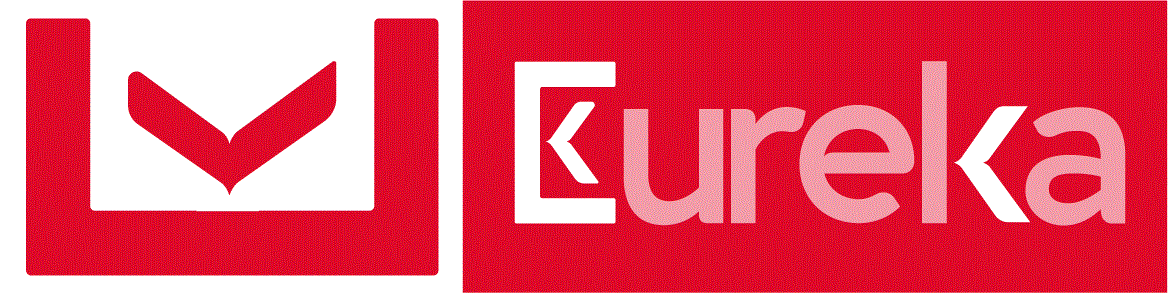Nelle ultime pagine de La casa della fame, il narratore-protagonista riporta le storie narrate da un anziano del ghetto. Si tratta però di storielle bizzarre, strampalate, che non soddisfano i cliché sull’ancestrale saggezza africana. Una delle storie fotografa perfettamente questo libro: “Uno scrittore tracciò un cerchio nella sabbia ed entrandoci disse: ‘Questo è il mio romanzo’, ma il cerchio spiccò un salto e lo tagliò da parte a parte”. Racconto arduo da definire, La casa della fame è un incessante combattimento che Marechera ingaggia con una serie di cerchi affilatissimi, a cominciare dallo spaventoso degrado del ghetto nero nella Rhodesia urbana degli anni ‘60/’70. L’incipit è una fuga dalla casa di famiglia, che però si inchioda subito di fronte allo squallore del panorama locale: “ebbi come la sensazione di passare in rassegna tutti i dettagli dello stronzo fetido che era stata ed era ancora in quel momento la mia vita”. La sete di vita del protagonista e della sua generazione (“non c’era oasi di pensiero che non prosciugavamo a furia di leccate”) si scontra con un vuoto di prospettive che ha “un appetito da lupo, e di cose vive”. Tra i lupi a manovrare questo vuoto, c’è la violenza razzista del regime bianco di Ian Smith, che non esita ad abbandonare cadaveri di guerriglieri di fronte alle scuole, a torturare studenti dissidenti come il narratore. C’è l’impietoso clima sociale del ghetto, anch’esso intriso di una violenza descritta da Marechera senza compromessi, inclusa l’educazione sessuale dei giovanissimi a stretto contatto con le prostitute locali: “un giorno seguimmo una donna per tutto il tragitto di ritorno al ghetto. Non c’era in lei niente di particolarmente interessante. È solo che mentre camminava la vedevamo colare sulla ghiaia della strada gocce e grumi di sperma.” E infine c’è la violenza famigliare dalla quale il protagonista cerca di fuggire, senza però riuscire ad andare oltre il bar locale ed iniziare una serie di ricordi e conversazioni con un panorama di avventori altrettanto devastati. Nella folgorante “Intervista dell’autore con se stesso” posta in appendice al racconto, Marechera individua le proprie influenze letterarie proprio nella devastazione sociale ed umana del ghetto dove è cresciuto, diventata una parte del suo essere: “Come si fa ad ‘osservare’ una pietra che ti sta per colpire? (…) Ero lì durante quelle orribili notti buie (i lampioni non hanno mai funzionato), ero i gemiti spettrali e i pianti quando qualcuno moriva e sapevi che sarebbe toccato seppellirlo nella discarica che chiamavano Cimitero dei nativi”. Cerchi taglienti, pietre scagliate, il colore rosso, il sangue, le cicatrici, ossa e denti spezzati abbondano ne La casa della fame, in un ribollire straziante che costituisce l’humus perfetto per l’insorgere dell’insanità mentale, cosa di cui Marechera stesso ha sofferto: “i colori della mente cominciarono a colare per la tela fino a sbavarsi l’un l’altro”. Anche i luoghi e gli oggetti sembrano animati da questo dolore onnipresente, da un’aggressività famelica che non ha requie: “i grani di ghiaia della strada digrignavano i denti sotto le mie scarpe maldestre”. La natura non offre alternative consolatorie alla sofferenza, anzi sembra esserne uno dei tanti prodotti: “Ho trovato un seme, un semino, il più piccolo del mondo. E si chiamava Odio. L’ho sotterrato nella mia mente e l’ho innaffiato con le lacrime. (…) Mentre si gonfiava e si schiudeva di vita verde ho sentito fremere la mia nazione, fremere dalle doglie; ed esplodere in rami e fiori”. Allo stesso modo, Marechera non fa sconti neanche alla cultura ancestrale e precoloniale, come giustamente nota Maria Paola Guarducci nell’articolo qui accanto: “hanno teso le ali della nostra razza, le hanno tese davanti al lume di candela. E niente è rimasto eccetto i genitali di divinità senili.” L’autobiografico protagonista sembra intravedere l’unica via di fuga, o perlomeno consolazione, nella letteratura. Da “cacalibri di merda” quale lui è, legge febbrilmente, scrive, cita e tesse nella sua narrazione una fitta tela di riferimenti intertestuali tratti dal canone africano e occidentale, dove la boscaglia circostante (zona di lavoro delle prostitute) può essere accostata al Preludio di Wordsworth. Sarebbe alquanto limitativo definire La casa della fame come libro di denuncia. In un certo senso lo è, ma allo stesso tempo è anche un raffinatissimo tour de force dove lo scheletro ributtante del ghetto viene incessantemente trasfigurato (ma non riscattato, sia chiaro) da un lirismo ipnotico e da una lisergica esuberanza metaforico-lessicale: “qualcosa nel suo sguardo sembrava forarmi come un forcone, forarmi e bucarmi le budella, finché si ritrasse di colpo e sembrò portarsi dietro anche le mie viscere”. A fronte di questo stile, la traduzione italiana trova soluzioni talvolta brillanti e nel complesso vince una sfida non certo facile. In maniera simile, la struttura del romanzo rifiuta la cifra del realismo sociale, costruendo una matrioska di storie, flashback e ricordi, storie come quelle dell’anziano del finale: “oblique, farneticanti, frammentarie”. Tornando all’immagine del cerchio affilato, quindi, la lotta di Marechera è innanzi tutto una lezione di stile, un rifiuto di restare al centro di qualsivoglia circolo della tradizione romanzesca, un tentativo di scombinare la gabbia di ogni possibile categorizzazione anticipando le mosse del cerchio, invece di attendere che sia lui a fare a fette il povero autore. Il talento geniale di Marechera è finalmente tradotto in italiano, e La casa della fame è il primo lungo racconto che dava il titolo alla raccolta del 1978; la speranza è che anche gli altri racconti, ed altre sue opere come il romanzo Black Sunlight (1980), possano essere presto disponibili per il nostro pubblico di lettori. Neanche sul proprio talento, però, il sarcasmo beffardo di Marechera abbassa la guardia. Al protagonista l’alcol va di traverso, quando qualcuno gli dice che i letterati sono l’unica speranza: “Allora siamo spacciati, pensai”. E l’anziano del finale esorta a non prendere troppo sul serio le sue storie, “farneticazioni di un vagabondo. Pezzetti e scampoli che ho trovato qua e là e mi sono messo in saccoccia”. Ma in realtà dovremmo essere noi lettori a prendere sul serio gli squarci di Marechera sulla realtà africana e sull’animo umano, così folgoranti da risultare, talvolta, addirittura profetici. Si prenda ad esempio questa citazione tratta dal romanzo postumo The Black Insider (1990): “Siamo un continente di rifugiati; un giorno qui, l’altro là. Tutti quanti carne da macello per i fabbricanti di confini. Non c’è più alcuna idea di casa, non c’è più il senso di essere in armonia con una qualsiasi parte della terra.” Ricorda qualcosa?
Cerchi affilatissimi
Deandrea Pietro
2019-01-01
Abstract
Nelle ultime pagine de La casa della fame, il narratore-protagonista riporta le storie narrate da un anziano del ghetto. Si tratta però di storielle bizzarre, strampalate, che non soddisfano i cliché sull’ancestrale saggezza africana. Una delle storie fotografa perfettamente questo libro: “Uno scrittore tracciò un cerchio nella sabbia ed entrandoci disse: ‘Questo è il mio romanzo’, ma il cerchio spiccò un salto e lo tagliò da parte a parte”. Racconto arduo da definire, La casa della fame è un incessante combattimento che Marechera ingaggia con una serie di cerchi affilatissimi, a cominciare dallo spaventoso degrado del ghetto nero nella Rhodesia urbana degli anni ‘60/’70. L’incipit è una fuga dalla casa di famiglia, che però si inchioda subito di fronte allo squallore del panorama locale: “ebbi come la sensazione di passare in rassegna tutti i dettagli dello stronzo fetido che era stata ed era ancora in quel momento la mia vita”. La sete di vita del protagonista e della sua generazione (“non c’era oasi di pensiero che non prosciugavamo a furia di leccate”) si scontra con un vuoto di prospettive che ha “un appetito da lupo, e di cose vive”. Tra i lupi a manovrare questo vuoto, c’è la violenza razzista del regime bianco di Ian Smith, che non esita ad abbandonare cadaveri di guerriglieri di fronte alle scuole, a torturare studenti dissidenti come il narratore. C’è l’impietoso clima sociale del ghetto, anch’esso intriso di una violenza descritta da Marechera senza compromessi, inclusa l’educazione sessuale dei giovanissimi a stretto contatto con le prostitute locali: “un giorno seguimmo una donna per tutto il tragitto di ritorno al ghetto. Non c’era in lei niente di particolarmente interessante. È solo che mentre camminava la vedevamo colare sulla ghiaia della strada gocce e grumi di sperma.” E infine c’è la violenza famigliare dalla quale il protagonista cerca di fuggire, senza però riuscire ad andare oltre il bar locale ed iniziare una serie di ricordi e conversazioni con un panorama di avventori altrettanto devastati. Nella folgorante “Intervista dell’autore con se stesso” posta in appendice al racconto, Marechera individua le proprie influenze letterarie proprio nella devastazione sociale ed umana del ghetto dove è cresciuto, diventata una parte del suo essere: “Come si fa ad ‘osservare’ una pietra che ti sta per colpire? (…) Ero lì durante quelle orribili notti buie (i lampioni non hanno mai funzionato), ero i gemiti spettrali e i pianti quando qualcuno moriva e sapevi che sarebbe toccato seppellirlo nella discarica che chiamavano Cimitero dei nativi”. Cerchi taglienti, pietre scagliate, il colore rosso, il sangue, le cicatrici, ossa e denti spezzati abbondano ne La casa della fame, in un ribollire straziante che costituisce l’humus perfetto per l’insorgere dell’insanità mentale, cosa di cui Marechera stesso ha sofferto: “i colori della mente cominciarono a colare per la tela fino a sbavarsi l’un l’altro”. Anche i luoghi e gli oggetti sembrano animati da questo dolore onnipresente, da un’aggressività famelica che non ha requie: “i grani di ghiaia della strada digrignavano i denti sotto le mie scarpe maldestre”. La natura non offre alternative consolatorie alla sofferenza, anzi sembra esserne uno dei tanti prodotti: “Ho trovato un seme, un semino, il più piccolo del mondo. E si chiamava Odio. L’ho sotterrato nella mia mente e l’ho innaffiato con le lacrime. (…) Mentre si gonfiava e si schiudeva di vita verde ho sentito fremere la mia nazione, fremere dalle doglie; ed esplodere in rami e fiori”. Allo stesso modo, Marechera non fa sconti neanche alla cultura ancestrale e precoloniale, come giustamente nota Maria Paola Guarducci nell’articolo qui accanto: “hanno teso le ali della nostra razza, le hanno tese davanti al lume di candela. E niente è rimasto eccetto i genitali di divinità senili.” L’autobiografico protagonista sembra intravedere l’unica via di fuga, o perlomeno consolazione, nella letteratura. Da “cacalibri di merda” quale lui è, legge febbrilmente, scrive, cita e tesse nella sua narrazione una fitta tela di riferimenti intertestuali tratti dal canone africano e occidentale, dove la boscaglia circostante (zona di lavoro delle prostitute) può essere accostata al Preludio di Wordsworth. Sarebbe alquanto limitativo definire La casa della fame come libro di denuncia. In un certo senso lo è, ma allo stesso tempo è anche un raffinatissimo tour de force dove lo scheletro ributtante del ghetto viene incessantemente trasfigurato (ma non riscattato, sia chiaro) da un lirismo ipnotico e da una lisergica esuberanza metaforico-lessicale: “qualcosa nel suo sguardo sembrava forarmi come un forcone, forarmi e bucarmi le budella, finché si ritrasse di colpo e sembrò portarsi dietro anche le mie viscere”. A fronte di questo stile, la traduzione italiana trova soluzioni talvolta brillanti e nel complesso vince una sfida non certo facile. In maniera simile, la struttura del romanzo rifiuta la cifra del realismo sociale, costruendo una matrioska di storie, flashback e ricordi, storie come quelle dell’anziano del finale: “oblique, farneticanti, frammentarie”. Tornando all’immagine del cerchio affilato, quindi, la lotta di Marechera è innanzi tutto una lezione di stile, un rifiuto di restare al centro di qualsivoglia circolo della tradizione romanzesca, un tentativo di scombinare la gabbia di ogni possibile categorizzazione anticipando le mosse del cerchio, invece di attendere che sia lui a fare a fette il povero autore. Il talento geniale di Marechera è finalmente tradotto in italiano, e La casa della fame è il primo lungo racconto che dava il titolo alla raccolta del 1978; la speranza è che anche gli altri racconti, ed altre sue opere come il romanzo Black Sunlight (1980), possano essere presto disponibili per il nostro pubblico di lettori. Neanche sul proprio talento, però, il sarcasmo beffardo di Marechera abbassa la guardia. Al protagonista l’alcol va di traverso, quando qualcuno gli dice che i letterati sono l’unica speranza: “Allora siamo spacciati, pensai”. E l’anziano del finale esorta a non prendere troppo sul serio le sue storie, “farneticazioni di un vagabondo. Pezzetti e scampoli che ho trovato qua e là e mi sono messo in saccoccia”. Ma in realtà dovremmo essere noi lettori a prendere sul serio gli squarci di Marechera sulla realtà africana e sull’animo umano, così folgoranti da risultare, talvolta, addirittura profetici. Si prenda ad esempio questa citazione tratta dal romanzo postumo The Black Insider (1990): “Siamo un continente di rifugiati; un giorno qui, l’altro là. Tutti quanti carne da macello per i fabbricanti di confini. Non c’è più alcuna idea di casa, non c’è più il senso di essere in armonia con una qualsiasi parte della terra.” Ricorda qualcosa?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.